
Ingrid Betancourt meritava di figurare tra i grandi premiati come Schweitzer, Luther King, Mandela, Madre Teresa ed Elie Wiesel. Ma non è l’unica esclusa: gli accademici di Svezia hanno avuto paura di premiare anche Gandhi e due dissidenti cinesi.
A che serve un Nobel per la pace? A premiare chi ha cercato soluzioni pacifiche dei conflitti e ha promosso la convivenza tra i popoli. Questa è la prima semplice risposta. Poi ce n’è un’altra. Il Nobel per la pace serve a risvegliare le coscienze, a scuotere i cuori, a proporre imperativi morali, a farci sentire nostro fratello, nostra sorella, chi ha sofferto per i diritti umani e contro le ingiustizie.
Gli accademici svedesi sono rimasti fermi alla prima risposta e hanno premiato Martti Ahtisaari: ex presidente della Finlandia, mediatore, negoziatore, tessitore di accordi, inviato dell’Onu nelle crisi difficili. Degnissima persona, per carità. Certamente un brav’uomo che merita riconoscenza. Ma non grande uomo. Non un nome che abbia una risonanza immediata nelle nostre coscienze, capace di infiammarci per migliorare, insieme, il mondo. Come hanno fatto altri premi Nobel per la pace.
Ricordo solo Albert Schweitzer, il medico missionario di Lambaréné, Nobel nel ’52; Martin Luther King, nel ’64, il profeta americano dei diritti civili dei neri, assassinato; Andrei Sacharov, nel ’75, lo scienziato perseguitato dal regime comunista; Madre Teresa di Calcutta, nel ’79, la suora che ha speso la vita per gli ultimi; Aung San Suu Kyi, nel ’91, la dissidente birmana ancora segregata in casa dalla giunta militare; Nelson Mandela, nel ’93, il sudafricano che ha messo fine all’apartheid. Ognuno di questi premiati ci trasmette una morale più alta. Ci insegna che val la pena affrontare persecuzioni e sofferenze per una causa sacrosanta.
C’è da chiedersi perché gli accademici svedesi non abbiano mai pensato di dare il Nobel a Gandhi, il profeta della nonviolenza, maestro di generazioni di pacifisti. Semplice: non volevano far dispetto all’Inghilterra, contro cui il Mahatma aveva combattuto per liberare l’India. E questo ci riporta all’oggi. La prudenza, il conformismo, il "politicamente corretto" guidano a volte le decisioni dei saggi che decidono il Nobel.
Tra i candidati di quest’anno c’erano due cinesi: Hu Jia e Gao Zhisheng , combattenti per i diritti umani in Cina, ora condannati per reati comuni. Ma la Repubblica popolare aveva mandato, più o meno apertamente, un avvertimento ai giurati del premio: i due dissidenti sono "criminali" e infatti stanno in carcere. La giuria del Nobel s’è adeguata: non si può urtare un grande Paese, si capisce.
E qui arrivo all’esclusione di un’altra candidata, Ingrid Betancourt. Ostaggio della guerriglia colombiana per più di sei anni, prigioniera nella giungla, ha mandato da quel buio un messaggio di dolore e di speranza, di orrore per la violenza e di passione per la giustizia. Sto leggendo il libro Lettera a mia madre, che raccoglie ciò che Ingrid scriveva quand’era sepolta nella foresta. La prefazione è di Elie Wiesel, sopravvissuto dell’Olocausto e Nobel per la pace nell’86. Scrive Wiesel: «Questa combattente per la libertà del genere umano, messa di fronte alla brutalità del male, mantiene intatti il suo ripudio dell’odio, la sua dignità, la fede nell’uomo». Il libro termina con l’elenco degli ostaggi ancora in mano della guerriglia. Un grido per invocare la loro liberazione.
Mi dispiace che non abbiano dato il Nobel a Ingrid. Ma penso che non occorre un riconoscimento tanto prestigioso per confrontarci con un’eroina disarmata che, con il coraggio e la forza morale, ci coinvolge nella causa della pace.
Franca Zambonini
fonte: Famiglia Cristiana
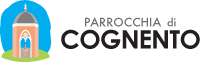

Lascia un commento