Vi proponiamo il testo dell’assemblea parrocchiale, che si è svolta venerdì 30 gennaio alle ora 20.30 in chiesa, per discutere della situazione temporanea e futura della nostra comunità.
Il relatore, don Massimo Nardello, ha preparato questa scaletta e in base agli interventi che ci saranno nell’assemblea e privatamente, aggiornerà il nuovo parroco sul contesto attuale della parrocchia.
Assemblea parrocchiale di Cognento
Traccia dell’intervento di don Massimo Nardello
30 dicembre 2016
1. Introduzione e informazioni
- Ringraziamenti a don Franco. Sarà disponibile per le confessioni in Duomo o in S. Bartolomeo e impegnato in altri servizi, ma non più nella parrocchia di Cognento per richiesta esplicita del Vescovo. Occorre aiutarlo ad esercitare il suo ministero in queste nuove modalità.
- La mia situazione di docente universitario e ricercatore nell’ambito teologico non mi consente di fare il parroco.
- Il mio ruolo attuale è quello dell’amministratore, parroco pro tempore che deve preparare la venuta del parroco vero.
- Nel frattempo ho confermato tutti i responsabili di settore, in particolare Giuseppe Giusti, Nino Roveda e Piero Cavazzuti del consiglio per gli affari economici e quest’ultimo anche come amministratore dell’asilo. Il consiglio pastorale resterà quello uscente, perché faremo solo una riflessione di verifica, e il futuro parroco eleggerà quello nuovo.
- Possibili scenari futuri della parrocchia: unione con una parrocchia vicina in modalità da definirsi o parroco residente.
- Difficoltà attuali della comunità:
- anche se è stato don Franco a chiedere di ritirarsi dalla parrocchia, il Vescovo gli ha chiesto di non restare in canonica e di ritirarsi definitivamente da qualsiasi ministero pastorale cognentese, sia per le problematiche indicate da d. Franco stesso (calo della memoria e delle forze) sia per lasciare campo aperto al nuovo parroco, cosa resa ulteriormente necessaria dalla situazione pastorale della parrocchia; del resto noi preti siamo formati a servire le comunità e a lasciarle, lo abbiamo scelto liberamente, come un genitore sa che deve crescere un figlio e poi lasciarlo andare per la sua strada;
- paura che chi verrà non sia capace di capire la situazione e di aiutare la comunità a camminare: è vero che noi preti siamo a volte un po’ autoreferenziali e non sempre all’altezza della situazione, ma quello che stiamo vivendo come comunità è anche un’occasione per ricordarci che il nostro vero pastore è il Signore Gesù, e che il nostro primo pastore umano è il vescovo; i preti sono suoi collaboratori, e possono e devono cambiare.
2. Il percorso della serata
- Vorrei aiutare la comunità a riflettere su:
- quali dovrebbero essere, a mio giudizio, le priorità pastorali di una comunità cristiana odierna;
- aspetti positivi e criticità degli operatori pastorali della parrocchia di Cognento.
- Vorrei raggiungere questo scopo con questa assemblea e incontrando poi singolarmente il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici, i catechisti, i capi scout, la caritas, i frati della casa della carità, il gruppo liturgico e il gruppo che organizza momenti ricreativi e di raccolta fondi.
- Il mio obiettivo sarà quello dell’ascolto. Riporterò al nuovo parroco e al vescovo quello che avrò notato.
- Ovviamente risolverò alcuni eventuali problemi pratici che richiedessero una soluzione tempestiva.
- Se qualche operatore pastorale avesse una necessità urgente, mi può contattare per email. Per sottopormi riflessioni più ampie, si può servire dei momenti di ascolto che intendo organizzare.
3. Le priorità di una comunità cristiana odierna
- Per capire le priorità pastorali di una comunità cristiana odierna dobbiamo partire dai cambiamenti drastici che si sono determinati nella società e nella Chiesa negli ultimi settant’anni.
- Veniamo da una situazione culturale ed ecclesiale in cui si era cattolici perché italiani e cresciuti in una famiglia cattolica. Questo rendeva inutile l’evangelizzazione, cioè il persuadere persone non credenti della bontà della fede in Gesù. Vi erano persone che militavano in ideologie anticristiane, ma erano difficilmente recuperabili.
- Si dava per scontato che le persone avessero fede e si cercava solo di rafforzarla (cura delle anime). La via maestra era quella della liturgia (messa, confessioni, ecc.) e degli altri riti (pellegrinaggi, processioni, novene, ecc.), nonché di una catechesi “dall’alto al basso”, cioè con minima interazione perché nessuno metteva in discussione l’autorità del parroco che insegnava la fede.
- In questa situazione culturale ed ecclesiale molte persone hanno vissuto autenticamente la vita cristiana facendo cammini di vera santità e di disponibilità al servizio in parrocchia.
- Altre persone hanno preso più o meno le distanze dalla fede, ma hanno mantenuto una certa identità cristiana di sottofondo legata al loro passato, unitamente alla pretesa che la parrocchia fosse comunque presente per offrire i servizi religiosi fondamentali (messe, battesimi, matrimoni, funerali, ecc.).
- Qualcuna di queste persone si è resa disponibile a collaborare con la proposta della parrocchia, e non sempre per ragioni di fede, ma anche perché vedeva nella comunità un luogo accogliente in cui si potevano fare delle cose buone.
- In questa visione riduttiva, in cui il cristianesimo è solamente parte delle tradizioni di famiglia o della propria esperienza giovanile, c’è bisogno che le strutture e le attività pastorali fondamentalmente non cambino: esso infatti è fortemente radicato nel territorio e nei propri edifici (chiesa, canonica, ecc,), ha bisogno di riferirsi ad un parroco stabile, idealmente quello della propria giovinezza, non accetta tanti cambiamenti nelle iniziative, ma anche negli arredi liturgici (statue, ecc.) e nella disposizione della Chiesa, perché tutto deve essere come è sempre stato.
- Questo modello di cristianesimo, però, non ha alcun futuro, perché suppone un mondo sociologicamente religioso che ormai non esiste più. Lo sperimentano soprattutto i genitori di figli adolescenti, che non di rado sono realmente atei.
- Le due caratteristiche del contesto postmoderno che inducono questa situazione sono:
- il valore assoluto della libertà come possibilità di reimpostare sempre la vita da capo senza troppi legami, e pure fonte di aspettative irrealistiche verso la vita (il lavoro perfetto, la fidanzata perfetta, ecc.) che creano forti frustrazioni;
- l’interesse esclusivo per la vita di quaggiù, e poiché il rapporto con Dio non serve a risolvere problemi pratici o a realizzare meglio il proprio bisogno di libertà, non interessa più;
- Così oggi diversi giovani sono realmente atei, sebbene non in senso ideologico e polemico, ma rispettoso verso chi fa scelte religiose.
- La soluzione pastorale a questa situazione non è affidarsi ad una spiritualità o ad un cammino particolare; questi elementi sono utili per coloro che sono chiamati ad essi, ma la comunità cristiana deve proporre un modello di fede possibile per tutti.
- Questo ci obbliga a ritornare al fondamento della fede e della vita ecclesiale, cioè al NT, con una domanda: come sono nate le prime comunità cristiane nell’ebraismo e nel paganesimo? Qui leggiamo che:
- il compito di cambiare i cuori e di guidare alla fede in Gesù è dello Spirito Santo e non nostro;
- lo Spirito però agisce nel cuore di chi non crede anzitutto non attraverso i sacramenti, ma l’annuncio della Parola di Dio.
- In effetti, nel NT la Chiesa nasce dal fatto che un credente comunica ad un altro la sua fede in Gesù, e questi accetta progressivamente di convertirsi e di aderire al Signore. Una comunità nasce e rinasce quindi dall’annuncio della Parola di Dio e dall’adesione di ciascuno dei suoi membri a questa Parola.
- Da questa continua adesione alla Parola di Dio nascono le altre attività della comunità cristiana, che sostanziano la sua vita comune e le sue attività:
- la celebrazione dei sacramenti, soprattutto dell’eucaristia, che porta al suo culmine l’accoglienza della Parola;
- la formazione, che vuole educare alla fede coloro che hanno fatto la scelta del cristianesimo;
- la missione, cioè la testimonianza della fede a chi vive del tutto al di fuori dei confini ecclesiali;
- l’attenzione ai bisognosi e il prendersi cura del territorio in cui si vive, con tutti gli uomini e donne di buona volontà, perché esso possa crescere verso il regno di Dio;
- Una comunità del genere vive una grande libertà dalle consuetudini rituali e organizzative e dai luoghi in cui si prega e si vive in comunità, perché ciò che conta non è il ricordo nostalgico delle esperienze religiose giovanili ma il Signore.
- Ora, mi sembra che per corrispondere alle esigenze pastorali del nostro tempo occorra dare il primato all’evangelizzazione, cioè alla comunicazione della Parola di Dio; questo però oggi deve avvenire in un contesto interattivo in cui sia possibile non solo ascoltare, ma anche dialogare di quanto si è ascoltato.
- In concreto:
- dietro ad ogni attività di evangelizzazione dovrebbe emergere una risposta alla domanda: perché essere cristiani?
- gli strumenti già disponibili a Cognento per perseguire questo fine sono il catechismo, gli scout e l’asilo.
- manca però la maggior parte delle strutture pastorali utili a tale scopo:
- gruppi di preghiera biblici per adulti, come quelli indicati dalla diocesi;
- catechesi per adulti con gruppi di lavoro seguenti;
- gruppi giovanili in cui parlare delle vicende della loro vita e, al loro interno, dell’alternativa cristiana;
- ritiri per tutti in cui poi ci sia un confronto guidato su quello che si è ascoltato.
- Questo significa che paradossalmente la cosa più importante che la Chiesa possiede, cioè l’eucaristia e gli altri sacramenti, non hanno più la priorità, perché la liturgia, anche se prevede momenti di ascolto della Parola, non è luogo di interazione e di scambio di vedute.
- Anche altre realtà tipicamente cognentesi, come i pellegrinaggi del 25 del mese, non possono più avere la priorità.
4. La situazione degli operatori pastorali della parrocchia di Cognento
- Aspetti positivi:
- vi sono molti operatori pastorali pazienti e generosi,
- vi è tanta ottima gente che si è allontanata dalla parrocchia per diverse ragioni e che è in attesa di un cambiamento pastorale e relazionale della comunità,
- vi sono tante famiglie giovani con aspettative importanti per la formazione dei loro figli che potrebbero rendersi disponibili al servizio in parrocchia.
- Problemi:
- i ruoli dei vari operatori pastorali non sono sempre chiari e talora non sono reciprocamente rispettati,
- tra gli operatori pastorali vi è talora un senso di solitudine e di mancanza di riconoscimento per il proprio servizio,
- si notano talora atteggiamenti di antagonismo tra operatori pastorali che hanno visioni diverse sulle scelte parrocchiali.
- Tutto questo ha portato ad una situazione un po’ caotica che, unitamente alle difficoltà pastorali della parrocchia, ha allontanato diverse persone.
- Ecco alcune indicazioni di fondo per affrontare gli aspetti problematici indicati:
- A differenza di ogni altra organizzazione, la comunità raccoglie persone che non si sono scelte, ma che sono state chiamate dal Signore. Questo significa che possono vivere in comunione solo accogliendo questo dono dalle sue mani e non per le loro capacità.
- Questo dono dell’unità, però, si compone con una profonda e sana diversità che riguarda diversi modi di vivere la medesima fede della Chiesa. Pensiamo ad esempio alla diversità delle varie vocazioni, alle diverse sensibilità tra i credenti nella liturgia e nella spiritualità cristiana, e così via. Queste diversità, se conformi con la fede della Chiesa, vanno rispettate come dono di Dio.
- Nello stesso tempo, la comunità vive tutte le dinamiche delle organizzazioni umane, per cui ha bisogno di ruoli ben definiti, che devono essere noti e rispettati da tutti, e di fare in modo che ogni persona possa svolgere un servizio che le risulti significativo, che cioè possa produrre qualcosa di proprio ed essere riconosciuta nel suo servizio.
- Occorre però superare l’idea che si possa essere più significativi nella misura in cui si raggiungono posizioni dominanti, o se si riesce a far passare “il proprio progetto”, “la propria idea”. La vita comunitaria non può diventare una lotta per il potere, neppure a fin di bene. Al contrario, occorre entrare in una logica di corresponsabilità: è la squadra che vince, e ciascuno deve impegnarsi non per il proprio successo personale, ma per far funzionare bene il gruppo in cui lavora.
- Infine propongo alcune norme sulla trasparenza nella gestione economica, non perché attualmente ci siano problemi, ma perché potrebbero nascere in futuro, come dimostra l’esperienza di altre comunità cristiane. La gestione dei soldi è una questione sempre molto complessa, e di soldi attorno ad una parrocchia ne girano tanti.
- Propongo questo principio di fondo: la verifica puntuale della correttezza dell’attività di ogni operatore pastorale che gestisce i beni della parrocchia non è in alcun modo espressione di mancanza di fiducia nei suoi confronti, ma necessaria garanzia e protezione sia contro la possibilità di commettere errori che di lasciarsi sedurre dalla ricchezza.
- Le norme che propongo, e che saranno oggetto di confronto, sono queste:
- il bilancio della parrocchia e dell’asilo, già disponibili per la visione da parte di ogni parrocchiano, dovrebbero essere rivisti d’ufficio da una commissione di tre saggi con un ruolo di mera supervisione; costoro potrebbero essere eletti dal parroco all’interno di una lista di nomi fatta dal consiglio pastorale e il loro incarico potrebbe durare un anno, senza poter essere rieletti immediatamente dopo aver completato un mandato; ovviamente non dovrebbero aver alcun incarico in parrocchia che comporti la gestione di denaro;
- devono essere di dominio pubblico e noti a tutta la comunità i nomi degli operatori pastorali che lavorano a titolo di puro volontariato, di coloro che percepiscono un mero rimborso spese (strettamente corrispondente alle sole spese sostenute per svolgere il proprio servizio) e di coloro che vengono pagati dalla comunità. Dal bilancio dovrà poi risultare l’ammontare complessivo degli stipendi erogati. Si noti che il volontariato non è necessariamente più nobile del lavoro salariato, perché di solito si tratta di due servizi differenti. Quest’ultimo garantisce una disponibilità e una professionalità che normalmente non possono essere offerte nella forma del volontariato;
- chi svolge qualsiasi attività di tipo economico per la parrocchia dovrà portare al consiglio per gli affari economici, e quindi al gruppo dei saggi, gli elementi necessari a mostrare che non ha ricavato alcun vantaggio economico personale dall’attività che ha svolto che non sia previsto dall’eventuale contratto di assunzione da parte della parrocchia o da accordi espliciti di rimborso;
- prima di appaltare un lavoro ad un’azienda o di acquistare beni o servizi, laddove sia in gioco una spesa di una certa entità, si richiederanno un certo numero di preventivi per poi scegliere quello più competitivo e per fugare eventuali dubbi di legami non trasparenti con qualunque azienda;
- i parenti stretti del parroco, dei membri del consiglio per gli affari economici e dei saggi in carica non potranno partecipare in alcun appalto della parrocchia, ma solo elargire beni e servizi a titolo gratuito.
5. Le domande
- Le domande su cui vorrei ascoltare il parere degli operatori pastorali negli incontri che seguiranno sono le seguenti.
- Cosa ne pensate della priorità dell’evangelizzazione per la nostra comunità? Se la condividete, quali cambiamenti occorrerebbe introdurre sul piano pastorale ed organizzativo per dare il primato all’evangelizzazione?
- Cosa ne pensate delle mie proposte più operative sugli aspetti relazionali, organizzativi ed economici della parrocchia?
- Cosa si potrebbe migliorare nell’organizzazione dei vari ambiti della vita parrocchiale?
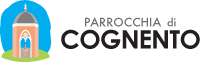





Lascia un commento